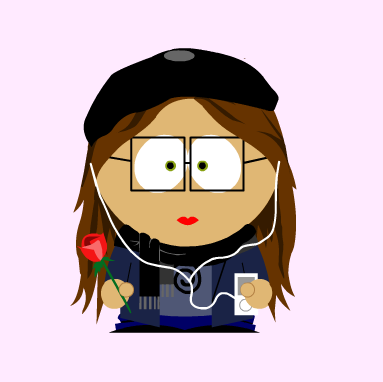Sempre della serie “la mia famiglia ed altri animali”, anche se sarebbe più da dire “gli animali e la mia famiglia”, sono le oche Gina e Pina.
Approdarono nei giardini circa tre anni fa, o quattro, per il compleanno di mia mamma. Mi sentirei in colpa se non aggiungessi che tutto partì da una mia battuta. Se avessi tenuto la boccaccia serrata, a questo punto non avremmo di questi problemi. Comunque sia, non si può cambiare il passato: quando mio papà, indeciso sul regalo da comprare, mi chiese un’opinione, io dissi, data la passione di mia mamma per qualsiasi cosa riguardi i simpatici bipedi bianchi e dondolanti, “ma prendiamo due oche!”. L’avevo detto per scherzo, però.
Mio papà l’aveva preso sul serio, così il pomeriggio si precipitò all’allevamento più vicino a casa, comprò due pulcini gialli e li chiuse in garage, dentro una cassetta di legno perché non scacazzassero sulla sua preziosa moto Guzzi. Il mattino dopo, sveglia presto per sgattaiolare a riprendere i pennuti, agghindarli con rispettivamente un fiocco rosso e uno rosa e portarli sotto il portico, sempre nella loro cassetta.
Allo starnazzare sconosciuto, mia mamma si affacciò al balcone e vide due pulcini gialli e strapazzati che imploravano amore materno. Le si sciolse il cuore.
Gli inizi furono idilliaci: era estate, e i piccoli ci zampettavano dietro ogniqualvolta uno di noi uscisse in giardino, e pigolavano perché ci fermassimo ad aspettarli. Erano così buffi, mentre arrancavano tra l’erba sempre troppo alta per loro, e li osservavamo orgogliosi mentre ci becchettavano affettuosamente le dita quando gli porgevamo dei fili d’erba da mangiare.
Purtroppo presto arrivò l’adolescenza, e con questa si presentarono anche squilibri mentali che non si erano mai manifestati prima. Intanto non erano più i dolci pulcini piumosi e soffici, ma due ocotti di mezza taglia, spennacchiati e bianchicci per la muta delle penne, che sbatacchiavano le ali ancora troppo piccole correndo per il giardino. Era uno spettacolo tristemente comico vedere gli sforzi dei due piumati per levarsi in volo, e noi aspettavamo che il cambiamento si completasse per avere finalmente i due bianchi pennuti che mia mamma sognava.
Un giorno, mentre la muta non era ancora completa, mio fratello aveva portato le due oche a fare un giretto per il giardino. Sedutosi, aveva iniziato a porgere i consueti fili d’erba ai pennuti, quando improvvisamente uno dei due, spalancate le ali e fissato l’umano con sguardo vuoto e minaccioso, gli si precipitò contro beccandolo nel mezzo della fronte. E questo fu l’inizio.
Un altro pomeriggio, mentre passavamo un dopo pranzo all’aperto bivaccando al tavolo ancora apparecchiato, arrivarono i nostri due cani –sempre loro, sì-, che iniziarono ad azzuffarsi fraternamente per farsi un po’ notare. Immediatamente, una delle due oche che stava militando attorno al tavolo per controllare che l’ordine regnasse e interpretava magistralmente il ruolo di carabiniere, si precipitò a separare i due litiganti, beccandoli abbondantemente su testa e fianchi. Non ho mai visto i miei cani scappare con uno scatto così veloce, e sì che ho passato due anni a vedermeli fuggire da sotto il naso.
Da quel giorno, i cani avrebbero girato bene al largo e con la coda tra le gambe, guardandosi bene dall’ avvicinarsi alla coppia di piumati gendarmi che pattugliava notte e giorno il giardino. Quando i cosiddetti migliori amici dell’uomo se ne andarono per diventare esperti pet-therapisti, sono sicura che i due pennuti si sentirono smodatamente compiaciuti nell’aver eliminato dalla scena due dei concorrenti al controllo del giardino.
Nello stesso tempo, iniziava a rendersi chiaro che i palmati due non erano Gina e Pina come avevamo tanto sperato, ma Gino e Pino. Niente uova di oca, quindi, e niente nuovi pulcinotti allegramente pigolanti ad animare il giardino.
Con l’arrivo dell’autunno, l’inizio della scuola e il rientro nel tran tran quotidiano, le oche –pardon, gli ochi- iniziarono a trascorrere molto tempo da soli. Non avevamo più la possibilità di seguirli e accompagnarli in lunghe passeggiate all’aperto, e loro pian piano si dimenticarono di noi; ci rimossero dal loro piccolo cervello. Le nostre facce non significavano più niente per loro, nonostante ci vedessero quotidianamente, e questo significò la rottura del rapporto: ci identificavano come estranei, e come tali andavamo allontanati.
Ma questo è quello che penserebbe una normale oca. Le nostre, con il loro delirio di onnipotenza, pensavano che in quanto estranei andassimo definitivamente eliminati, e per proseguire nel loro intento ci puntavano a collo teso e ali spalancate, starnazzando in modo ben poco amichevole ogniqualvolta osassimo mettere il naso nella loro area di competenza. Il che significava ogni volta che si metteva il naso fuori di casa, perché le due pennute si erano bizzarramente convinte di essere padrone dell’universo.
Sfortunatamente non ci fu mai modo di farci riconoscere nuovamente come amici, e nonostante l’arrivo della primavera seguente e la nostra presenza sempre più assidua in giardino, le due continuavano imperterrite a puntarci e farci fare di quelle corse che alle Olimpiadi se le sognano.
Era diventato un problema anche solo aprire il cancelletto del loro recinto: non appena il chiavistello scattava, le due si precipitavano contro l’usciere, costringendolo a doverose ma poco onorevoli ritirate accompagnate da ululati di terrore e strilli riecheggianti.
Per darci un contegno e tentare di sottrarci al tristo destino di venire sottomessi da una coppia di oche –oche!-, iniziammo a girare per il giardino muniti di bastone.
Non sto scherzando. Provate voi a farvi attaccare da una coppia di oche –permettetemi di continuare a sottolinearlo, perché vorrei mettere totalmente a fuoco la questione: stiamo parlando di oche. Qua-qua. Zampe palmate e coda scodinzolante a ritmo con l’andatura a dondolo. Non parlo di Rottweiler né di zebre scalcianti. Quelle che avevano preso il potere nel nostro giardino erano due oche.- oche assatanate, dicevo, e vediamo poi chi ride. La situazione era diventata pericolosa: non si poteva più uscire di casa senza sentire il feroce sibilo alle spalle. A quel punto si rientrava, ci si blindava la porta alle spalle e –dopo opportuni riti di incoraggiamento guardandosi allo specchio e gonfiando i muscoli- si usciva solamente armati.
Purtroppo, con l’arrivo dell’inverno seguente, una tragedia accorse.
Mentre eravamo lontani da casa –il tutto nei giorni della merla, un freddo cane che non si immaginava-, le due oche erano riuscite ad evadere dal recinto e, preparando piani di assalto alle macchine una volta saremmo tornati a casa, si erano date alle passeggiate di complotto.
Un giorno le passeggiatine finirono: uno dei due allegri compagni si avventurò nella piscina, allora ghiacciata, e, forse dopo strenue lotte per uscire, forse abbandonandosi languidamente al freddo, annegò.
Forse si trattava di suicidio, perché è il primo caso di oca annegata di cui sento parlare.
Quando tornammo, trovammo il macabro spettacolo dell’oco a ali spalancate e collo affogato, mentre il suo compagno lo aspettava a bordo vasca, starnazzando e chiamandolo affinché uscisse e la smettesse di scherzare, dato che iniziava a preoccuparlo. Era una scena di una tristezza infinita.