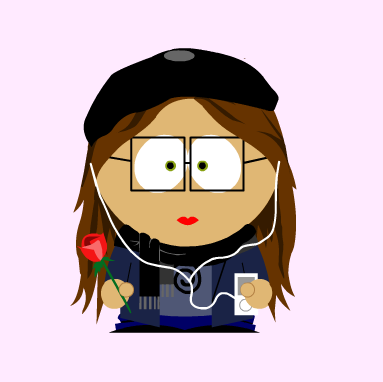Asfalto. Linea continua, linea spezzata.
Limpida trasparenza di luna a inondare l'aria.
Dieci di sera, sulla strada.
Pedala, pedala, pedala sulla bicicletta bianca, vecchia bicicletta un tempo della mamma. Sciarpa annodata che copre il naso, naso freddo d'autunno.
Mentre pedala segue la luna, ipnotica e perlacea, pura nella luce riflessa che spande senza metro.
La ruota scorre, nero nel nero, asfalto nella notte, copertone nell'asfalto, nero nella mente e nel petto, nero che si scioglie in catrame, in sangue che non scorre, pietrificata in una tristezza di pesante depressione.
La mente scivola, i pensieri si mangiano la coda, risuonano nella mente ululando.
Gli occhi scappano sulla strada; rapidi fuggono alla luna, bevono la luce che si specchia nelle pupille.
“signora luna, che mi accompagni, per tutto il mondo”
voce sommessa e fiato spezzato dalla corsa
“puoi tu spiegare, qual'è la strada, che porta a me”
risuona debolmente nella strada deserta, rimbalzando sugli specchietti delle automobili ferme al buio dei lampioni spenti
“non me ne venga, signora luna, se non ho amato”
memoria che vacilla, la canzone serpeggia tra i versi disordinatamente
e poi ricomincia
“signora luna, che mi accompagni, per tutto il mondo”
rauca e bassa
la luce è riflessa dall'acciaio del manubrio. Pare un fantasma scuro, perso nella periferia della città, circondata da quella strana luce notturna, un'aura debole attorno a lei.
Pedala pedala pedala
La ruota scorre, nero nel nero, asfalto nella notte, copertone nell'asfalto, nero nella mente e nel petto, nero che si scioglie in catrame, in sangue che non scorre, pietrificata in una tristezza di pesante depressione.
La mente scivola, i pensieri si mangiano la coda, risuonano nella mente ululando.
Gli occhi scappano sulla strada; rapidi fuggono alla luna, bevono la luce che si specchia nelle pupille.
“signora luna, che mi accompagni, per tutto il mondo”
voce sommessa e fiato spezzato dalla corsa
“puoi tu spiegare, qual'è la strada, che porta a me”
risuona debolmente nella strada deserta, rimbalzando sugli specchietti delle automobili ferme al buio dei lampioni spenti
“non me ne venga, signora luna, se non ho amato”
memoria che vacilla, la canzone serpeggia tra i versi disordinatamente
e poi ricomincia
“signora luna, che mi accompagni, per tutto il mondo”
rauca e bassa
la luce è riflessa dall'acciaio del manubrio. Pare un fantasma scuro, perso nella periferia della città, circondata da quella strana luce notturna, un'aura debole attorno a lei.
Pedala pedala pedala
mente distratta
la luna nascosta dietro un albero, il buio. Splendore spento.
due fari senza precedenza, veloci, troppo veloci
Asfalto.
la luna nascosta dietro un albero, il buio. Splendore spento.
due fari senza precedenza, veloci, troppo veloci
Asfalto.